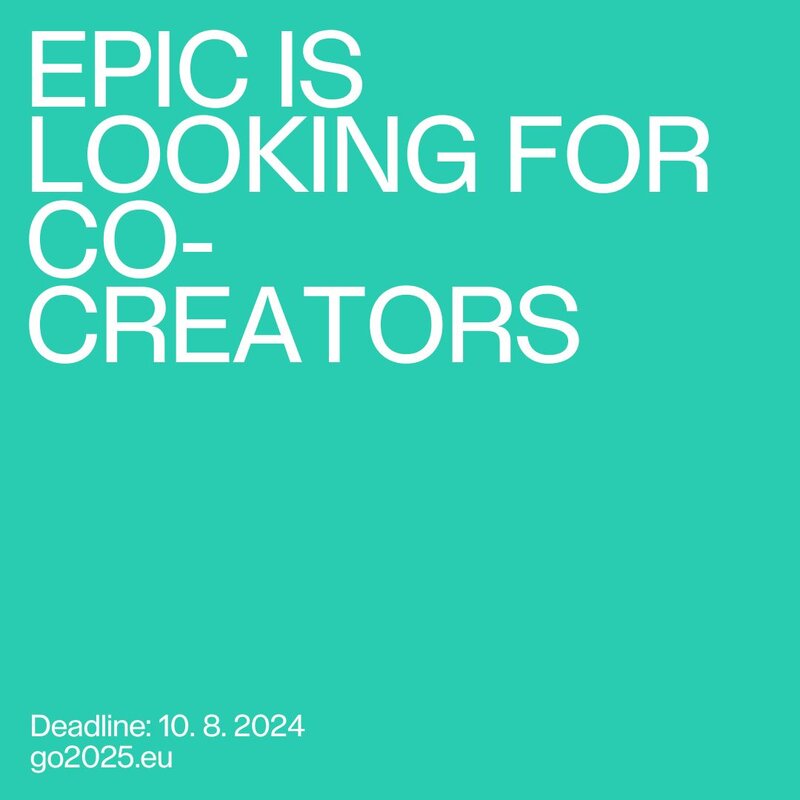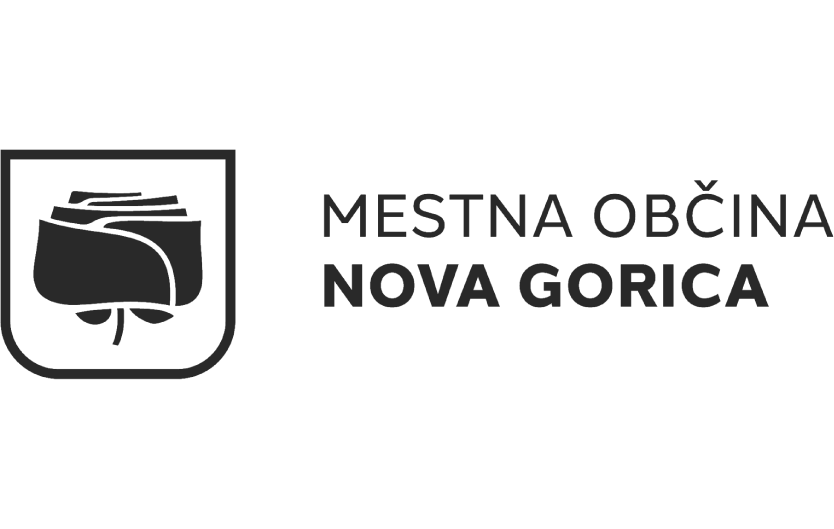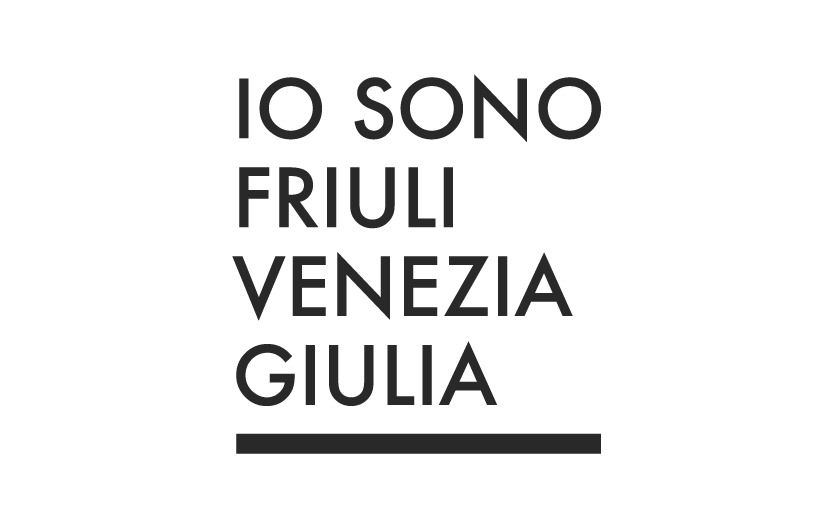26/11/2025

Undici paesi – Belgio, Francia, Slovenia, Italia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Germania, Austria, Romania e Ucraina; numerose istituzioni – musei, municipalità, enti per la tutela del patrimonio, enti del turismo, centri di sviluppo regionale e organizzazioni scientifiche. Ma un'unica idea condivisa: proteggere, interpretare, studiare e rivitalizzare il patrimonio della Prima Guerra Mondiale attraverso un approccio autenticamente transnazionale.
Sotto la guida del Centro di Sviluppo Regionale dell'Isonzo (Posoški Razvojni Center) e della Fondazione Sentiero della Pace (Walk of Peace Foundation), questa variegata rete riunisce diversi partner per esplorare come i paesaggi delle ex linee del fronte possano essere trasformati in spazi di dialogo, educazione e sviluppo sostenibile.
Questo lavoro si svolge nell'ambito del progetto GOV4PeaCE – un modello di governance multidimensionale e trans-territoriale nato per attivare l'eredità della Prima Guerra Mondiale e promuovere uno sviluppo socio-economico sostenibile nelle aree periferiche dell'Europa centrale, cofinanziato dall'Unione Europea come progetto Interreg Central Europe.
Perché è importante una narrazione comune? Come si possono collegare le diverse tradizioni nazionali della memoria? E quale ruolo possono svolgere musei, ricercatori e comunità locali nel plasmare una memoria europea condivisa della guerra?
Queste sono le domande al centro di questa intervista, che vede protagonisti i rappresentanti delle istituzioni chiave impegnate nella costruzione di una nuova prospettiva transfrontaliera sull'eredità della Grande Guerra. È il racconto di come una storia un tempo divisa possa diventare le fondamenta per un futuro europeo condiviso.
Klavdija Figelj (European Capital of Culture Nova Gorica-Gorizia 2025) in conversazione con: Francesco Frizzera (Museo Storico Italiano della Guerra), Maša Klavora (Walk of Peace Foundation), Stephen Lodewyck (In Flanders Fields Museum, Ypres), Kamil Ruszała (Università Jagellonica), Petra Svoljšak (ZRC SAZU – Accademia Slovena delle Scienze e delle Arti)
La seguente intervista riunisce i rappresentanti delle principali istituzioni europee coinvolte nel progetto GOV4PeaCE per discutere come l'eredità della Prima Guerra Mondiale possa fungere da fondamento per la cooperazione transnazionale e lo sviluppo sostenibile. Sotto il titolo “Patrimonio Transnazionale della Guerra: Trasferimento di Conoscenza e Sviluppo Sostenibile Oltre i Confini”, la conversazione esplora come i partner provenienti da Slovenia, Polonia, Slovacchia, Ungheria, Italia, Francia, Germania, Romania, Belgio e Ucraina lavorino insieme per reinterpretare e preservare l'eredità del conflitto attraverso la ricerca, l'istruzione e le pratiche museali condivise.
Mettendo in relazione le conoscenze accademiche con la gestione del patrimonio a livello locale e internazionale, il dialogo mira a sottolineare come la memoria collettiva possa promuovere la pace, la resilienza e lo scambio culturale oltre i confini – trasformando i resti del conflitto in uno spazio vivo di cooperazione e apprendimento per le generazioni future.
La Dimensione Transnazionale
L'eredità della Prima Guerra Mondiale si estende ben oltre i confini nazionali. La sua conservazione e interpretazione richiedono uno sforzo collettivo, un dialogo e una comprensione reciproca tra i Paesi un tempo divisi dal conflitto. Perché la cooperazione internazionale tra Slovenia, Polonia, Slovacchia, Italia, Belgio, Francia, Ungheria, Romania, Ucraina e altri è così cruciale in un progetto che si occupa del patrimonio della Prima Guerra Mondiale?
Maša Klavora (Walk of Peace Foundation):
Poiché la Prima Guerra Mondiale è stata un conflitto globale, ha avuto un impatto su persone e paesaggi ovunque, indipendentemente dalla fazione in cui si trovavano – e le sue tracce continuano a modellare le comunità e gli ambienti odierni. Il patrimonio della Prima Guerra Mondiale è stato creato da popoli, nazioni e culture differenti, e commemora diversi gruppi di vittime. Ciò lo rende un patrimonio e una storia condivisi per molti di noi, indipendentemente dalla sua ubicazione. Esso forma una memoria collettiva, non solo individuale o familiare. Oggi, l'eredità della Prima Guerra Mondiale possiede un eccezionale valore universale e un significato nettamente transnazionale, oltre a una importante responsabilità. Per comprendere veramente le sue molteplici narrazioni – e le emozioni e le interpretazioni delle generazioni attuali – questa storia deve essere ricercata da specialisti provenienti da Paesi e prospettive diversi. Solo la cooperazione transfrontaliera e transnazionale può consentire un autentico scambio di conoscenze, idee e migliori pratiche, incoraggiare progetti congiunti e permetterci di incontrarci, imparare gli uni dagli altri e confrontare sia il nostro passato comune sia quello distinto. Questa forma di cooperazione è, di per sé, un percorso verso la pace e la riconciliazione. Affrontare il patrimonio e la storia a livello transnazionale, piuttosto che unicamente all'interno di framework nazionali, ne accresce significativamente la rilevanza per le società contemporanee. L'Europa – e il mondo – hanno bisogno di storie, esperienze e pratiche così riflessive ora più che mai.
Stephen Lodewyck (In Flanders Fields Museum): Sebbene i confini nazionali fossero ancora rilevanti immediatamente prima dell'inizio della Prima Guerra Mondiale, la loro importanza svanì a seguito delle operazioni belliche. Le caratteristiche geografiche del paesaggio, al contrario, divennero sempre più cruciali. Il vasto patrimonio della Prima Guerra Mondiale si trova principalmente nei paesaggi delle ex linee del fronte che attraversano i confini nazionali. Tuttavia, la sua conservazione e divulgazione seguono spesso standard, regolamenti e prospettive regionali o nazionali. Dato che il conflitto è stato fondamentalmente transnazionale nelle sue cause, esperienze e conseguenze a lungo termine, nessun singolo Paese detiene l'intera narrazione. Poiché il paesaggio storico della guerra si estende attraverso l'Europa, la sua comprensione richiede l'unione di conoscenze e prospettive provenienti da diverse regioni. I diversi quadri normativi per la protezione possono essere valutati attraverso uno sforzo congiunto, dal quale possiamo imparare reciprocamente ed eventualmente armonizzare gli standard. Questa necessità di collaborazione riflette anche un più ampio cambio storiografico: la Prima Guerra Mondiale è sempre più affrontata non come una serie di storie nazionali isolate, ma come un'esperienza europea condivisa. Rafforzare questa prospettiva richiede una rete stabile di partner internazionali in grado di scambiare expertise e ricerca, e così plasmare collettivamente un'interpretazione più completa della storia della guerra. Una solida cooperazione tra questi partner, attraverso un dialogo approfondito sull'interpretazione della storia e del suo patrimonio, mira a raggiungere un quadro di valori condiviso riguardo alle perdite causate dalla guerra e all'importanza di (lavorare per) la pace e le sue condizioni.
Kamil Ruszała (Jagiellonian University): Il Fronte Orientale attraversò diversi confini odierni, creando un paesaggio di storia condivisa che non può essere compreso attraverso un'unica lente nazionale. La cooperazione tra i diversi Paesi della regione ci permette di connettere archivi frammentati, cimiteri e culture della memoria in un'unica narrazione coerente. Ciascun Paese conserva solo una parte dell'esperienza bellica, unica per quel contesto; tuttavia, solo lavorando insieme possiamo ricostruire la piena portata di ciò che la guerra ha comportato: a partire da sfollamento, violenza, distruzione e ricostruzione, ma anche la creazione di un nuovo paesaggio culturale e materiale che necessita di una definizione appropriata. La collaborazione transnazionale contribuisce anche a armonizzare gli standard di conservazione e sostiene le istituzioni locali che spesso operano in isolamento. Soprattutto, rafforza l'idea che il patrimonio della Prima Guerra Mondiale appartenga all'intera Europa, e non ai singoli canoni nazionali.
Petra Svoljšak (ZRC SAZU, Milko Kos Historical Institute): La Prima Guerra Mondiale fu il primo grande conflitto a carattere di massa sotto molti aspetti: mobilitazione di massa, morte di massa, rifugiati di massa, distruzione di massa. A distanza di oltre cento anni, i resti, il patrimonio e l'eredità di questa guerra ci ricordano la necessità di imparare dagli errori del passato per preservare la pace. Infatti, molti degli attuali conflitti rappresentano l'eredità della Prima Guerra Mondiale, così come le decisioni geopolitiche e le pratiche di gestione delle risorse umane che ne sono scaturite. L'impegno della società civile, della scienza e dei musei a lavorare in modo transnazionale sul tema del patrimonio della Prima Guerra Mondiale è un passo importante verso la comprensione reciproca, la conoscenza condivisa e il superamento dei pregiudizi, che spesso conducono a conflitti e incomprensioni. È inoltre fondamentale connettere diverse parti d'Europa che hanno avuto esperienze belliche molto differenti, nonché politiche di memorizzazione e pratiche commemorative diverse nel dopoguerra.
Colmare le Tradizioni Nazionali della Memoria per una Comprensione Transnazionale
Ogni nazione ricorda la Prima Guerra Mondiale attraverso la propria lente culturale. Eppure, la sfida più grande – e contemporaneamente l'opportunità – risiede nel creare una narrativa europea condivisa che abbracci la diversità promuovendo al contempo il dialogo. Quali sono le principali sfide nel connettere le diverse tradizioni nazionali della memoria all'interno della cornice dello stesso progetto?
Petra Svoljšak (ZRC SAZU): La sfida principale risiede nella conoscenza e nel superamento di una narrazione della Prima Guerra Mondiale spesso incentrata sull'Europa Occidentale. La cooperazione transnazionale è dunque di importanza fondamentale per superare le differenze e promuovere una narrazione condivisa, rispettando le diversità e riconoscendo l'importanza della collaborazione transfrontaliera e transnazionale in tutti i campi che si occupano del patrimonio bellico. La creazione di una rete di istituzioni e individui lungo i vecchi fronti è la pratica migliore e più efficiente per formare una narrativa paneuropea della Prima Guerra Mondiale, nel rispetto delle singole tradizioni. D'altra parte, è cruciale sensibilizzare su una memoria complessiva e un patrimonio connettivo della guerra che contribuisca a superare l'ignoranza, promuovendo una cultura di pace e coesistenza.
Francesco Frizzera (MITAG): Il principale ostacolo nel promuovere una narrativa europea condivisa è la gestione della tensione intrinseca tra le distinte tradizioni nazionali della memoria e la necessità di una comprensione transnazionale. Ogni nazione filtra la Prima Guerra Mondiale attraverso la propria lente culturale, spesso solidificata da retoriche monolitiche stabilite dagli stati successori o vincitori. Queste narrazioni, concepite per costruire l'unità nazionale, hanno storicamente oscurato le esperienze delle minoranze e dell'”altro”, generando prospettive storiche diversificate e disparati livelli di infrastrutture del patrimonio in tutta Europa. Questo rende la conciliazione delle diverse tradizioni commemorative e sensibilità una sfida significativa. Tuttavia, l'immensa opportunità risiede nello sfruttare la natura unica delle aree di confine e degli spazi post-imperiali. In questi contesti, l'esperienza storica è molto più sfumata: le storie individuali – come i nonni che hanno combattuto su fronti opposti – creano una tensione dinamica che resiste a letture semplicistiche e teleologiche della storia. In questi ex territori multietnici, la commemorazione patriottico-nazionale può spesso risultare superficiale o imposta. Esistono invece forme di memoria più profonde e radicate, che possiedono un valore universale che trascende vincitori e vinti. Questi trasferimenti culturali preesistenti e le storie condivise negli ambienti post-imperiali favoriscono naturalmente piattaforme per la coesistenza comune, rendendo queste regioni i luoghi più promettenti per lo sviluppo di una narrativa inclusiva e transnazionale che abbracci genuinamente la diversità e promuova il dialogo.
UNESCO e il Quadro del Patrimonio Europeo
Il Sentiero Europeo della Pace (European Walk of Peace Trail) mira a diventare parte della rete di percorsi del patrimonio riconosciuti dall'UNESCO, collegando i siti della Prima Guerra Mondiale in tutta Europa sotto un messaggio condiviso di pace e riconciliazione. In che modo l'idea di sviluppare il Sentiero Europeo della Pace si relaziona con il processo di candidatura UNESCO?
Stephen Lodewyck (In Flanders Fields Museum), È fondamentale comprendere a fondo i valori che sono alla base del riconoscimento come Patrimonio Mondiale UNESCO, al fine di garantire che il Sentiero Europeo della Pace sia allineato il più strettamente possibile con un processo di candidatura. Il "Valore Universale Eccezionale" (VUE) richiede un significato culturale e/o naturale così eccezionale da trascendere i confini nazionali ed essere di interesse comune per le generazioni presenti e future dell'intera umanità. La protezione continua di tale patrimonio è pertanto della massima importanza per la comunità internazionale nel suo complesso. Sono convinto che collegare i siti della Prima Guerra Mondiale in modo fisico e transnazionale, incarnando un messaggio di pace condiviso, abbia il potenziale per soddisfare questi Valori Universali Eccezionali, proprio come è stato raggiunto dai siti commemorativi della Prima Guerra Mondiale sul Fronte Occidentale.
Maša Klavora (Walk of Peace Foundation): Uno dei più forti Valori Universali Eccezionali (VUE) – e un elemento chiave per qualsiasi candidatura UNESCO – del Sentiero della Pace e di (almeno alcune parti del) patrimonio della Prima Guerra Mondiale è il messaggio di pace. Poiché la Prima Guerra Mondiale è stata un conflitto globale, con siti di patrimonio significativi ancora visibili in molti Paesi e portatori di un chiaro significato transnazionale, il Sentiero della Pace potrebbe diventare una candidatura seriale transnazionale. Tale candidatura avrebbe un potente valore simbolico sia per il passato che per il presente: Sosterrebbe la memoria condivisa di tutte le vittime; Promuoverebbe la riconciliazione oggi; Contribuirebbe allo sviluppo sostenibile delle regioni un tempo devastate dalla guerra. Il nome della candidatura è inoltre essenziale: Sentiero della Pace (Walk of Peace). Sebbene racconti la storia della guerra, comunica un messaggio positivo e proiettato al futuro — un messaggio di speranza, ottimismo e impegno per l'avvenire. È importante sottolineare che non si rivolge solo agli storici, ma coinvolge anche un pubblico più ampio e diversi target group.
Kamil Ruszała (Jagiellonian University): Per il Fronte Orientale, aderire all'iniziativa del Sentiero della Pace offre un'opportunità unica per collocare questa regione, spesso trascurata, sulla mappa del patrimonio europeo. Una candidatura UNESCO richiede documentazione basata sulla ricerca, strutture di gestione a lungo termine e una narrazione transfrontaliera condivisa. In tutte queste aree, le università e le istituzioni di ricerca svolgono un ruolo cruciale. Il nostro obiettivo è contribuire con l'esperienza accademica per estendere il percorso verso Est, collegando i siti in Polonia, Slovacchia, e persino, nel prossimo passo oltre questa regione, con quelli già riconosciuti in Slovenia e Italia, nonché in Belgio. Questo fornisce una cornice per una futura comprensione transnazionale del passato. Costruendo solide partnership con municipalità, musei e ONG, speriamo di dimostrare che il patrimonio del Fronte Orientale porta lo stesso messaggio universale di pace e riconciliazione degli altri paesaggi europei della Prima Guerra Mondiale.
Il Ruolo della Scienza e delle Istituzioni Accademiche
Poiché la discussione ha già toccato il ruolo delle università e l'idea del "dalla ricerca alla società" (research to society), continueremo chiedendo come la ricerca e l'istruzione – che sono il cuore dell'interpretazione del patrimonio – consentano alle università e alle istituzioni accademiche di fornire le prove, il contesto e le narrazioni che trasformano la storia in cultura viva: Qual è il ruolo della scienza e delle istituzioni accademiche nel progetto GOV4PeaCE, e in che modo la collaborazione tra ricercatori, musei e autorità locali rafforza i suoi risultati e la sua sostenibilità a lungo termine?
Maša Klavora (Walk of Peace Foundation): Il tema centrale di GOV4PeaCE è la governance: ovvero come migliorare la gestione del patrimonio della Prima Guerra Mondiale attraverso il supporto e l'inclusione di diversi settori – comuni, musei, centri di ricerca, ONG, istituti di tutela del patrimonio, agenzie di sviluppo regionale e mondo dell'istruzione. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile un solido lavoro di ricerca, che compari l'analisi delle migliori pratiche e metta a confronto conoscenze diverse. Il Walk of Peace (Sentiero della Pace) deve svilupparsi attraverso un approccio sia dal basso (bottom-up) che dall'alto (top-down), operando in un'ottica multisettoriale, multidimensionale e multilivello. Per fare un esempio concreto, lo ZRC SAZU e PromoTurismoFVG supportano da anni i partner in Slovenia e in Italia nella definizione di standard professionali e transfrontalieri per la gestione di questo patrimonio. Allo stesso tempo, l’Università Jagellonica – e in particolare la Facoltà di Storia e il Critical Heritage Studies Hub – apporta al progetto una prospettiva innovativa dall’Europa centro-orientale, offrendo modelli di tutela e attivazione del patrimonio che mettono in rete istituzioni pubbliche, musei, ONG, turismo e istruzione. Le loro ricerche sui paesaggi dei campi di battaglia, sull'archeologia del conflitto e sulla ricostruzione di siti perduti o dimenticati si sono rivelate cruciali per identificare luoghi di sepoltura e comprendere le tracce materiali della guerra. Questa competenza non è preziosa solo per i partner dell'Europa centro-orientale, ma offre un supporto diretto anche agli stakeholder in Slovenia e in Italia, aiutandoli a riconoscere la natura transnazionale del patrimonio della Grande Guerra e ad attuare modelli di governance più integrati e sostenibili.
Stephen Lodewyck (In Flanders Fields Museum): La collaborazione tra la ricerca nei musei e la ricerca nelle istituzioni accademiche dovrebbe portare a una fecondazione incrociata (cross-fertilization). I ricercatori nei musei inseriscono determinati argomenti e temi nell'agenda della ricerca accademica, integrano i risultati della ricerca con le conoscenze derivanti dalla pratica sul campo e traducono concretamente i risultati della ricerca del settore accademico in mostre accessibili e programmi pubblici. Nel frattempo, le autorità locali integrano questi insight nelle strategie di pianificazione, turismo e conservazione. Questa fecondazione incrociata non solo migliora la qualità degli output del progetto, ma rafforza anche il coinvolgimento della comunità e la sostenibilità a lungo termine. Le conoscenze che l'In Flanders Fields Museum ha sviluppato in passato grazie a questa collaborazione vengono condivise, laddove rilevanti, con i partner nella creazione di un modello di governance e applicate nelle azioni e nei pacchetti di lavoro di cui il museo è responsabile.
Francesco Frizzera (MITAG): Le istituzioni accademiche sono centrali nel progetto GOV4PeaCE, agendo come i principali motori del cambiamento facilitando il "dalla ricerca alla società" (research to society) e il "dalla ricerca allo sviluppo" (research to development). Università e centri di ricerca, come ZRC SAZU e l'Università Jagellonica, sono essenziali per fornire le prove, il contesto e le narrazioni rigorose necessarie a trasformare il dato storico in cultura viva e in strumenti di gestione del patrimonio sostenibili. Essi guidano il processo di trasferimento di conoscenza dal regno accademico all'applicazione pratica. Nel caso studio del Trentino, la collaborazione tra l'università e i musei territoriali ha esemplificato questo ruolo spostando radicalmente il discorso pubblico. I ricercatori hanno riportato in luce i soggetti "dimenticati" – combattenti in uniforme austro-ungarica, donne, prigionieri e bambini – che erano stati precedentemente emarginati dalla retorica patriottica nazionale. Evidenziando i loro movimenti, i loro destini e le esperienze condivise, come il fenomeno dei rifugiati e dello sfollamento, i ricercatori hanno generato un diffuso senso di consapevolezza pubblica e un desiderio collettivo di riscoprire un passato precedentemente nascosto. Questo insight è stato poi tradotto in risultati tangibili: mostre, piattaforme digitali e viaggi comunitari, ad esempio in Boemia o Moravia, dove gli abitanti locali hanno visitato i luoghi di sepoltura dei loro antenati. Ciò dimostra come la collaborazione accademica rafforzi i risultati, garantendo che la gestione del patrimonio sia radicata in una comprensione storica accurata e sfaccettata.
Impatto Sociale ed Educativo
Oltre alla conservazione, i progetti sul patrimonio come GOV4PeaCE fungono anche da piattaforme educative che insegnano empatia, pace e consapevolezza storica. Vale quindi la pena chiedere: Qual è il significato accademico e sociale di GOV4PeaCE per le generazioni future? In che modo le narrazioni di guerra possono aiutarci a riflettere sulle sfide odierne, come i conflitti e la resilienza? Quale messaggio sull'eredità della Prima Guerra Mondiale e sulla cultura della pace desiderate trasmettere al pubblico europeo?
Petra Svoljšak (ZRC SAZU): Il punto di partenza per comprendere l'importanza del patrimonio della Prima Guerra Mondiale è la conoscenza delle conseguenze a lungo termine di questa guerra, anche per gli attuali conflitti armati e il loro impatto sul mondo contemporaneo. I siti della memoria e della commemorazione trasmettono alle giovani generazioni tutta l'assurdità e gli esiti tragici del conflitto a livello personale, locale, nazionale e globale. I luoghi di lutto che si sono trasformati in siti di memoria condivisa e comune possono insegnare l'importanza della tolleranza e della convivenza. Le nuove generazioni possono apprendere l'importanza di una società inclusiva, in cui ogni voce conta e in cui il multiconfessionalismo, il multiculturalismo e il multilinguismo arricchiscono la società. I valori promossi dal progetto GOV4PeaCE non riguardano solo politiche comuni nella conservazione e nell'interpretazione del patrimonio, ma sono soprattutto focalizzati sulla creazione di una società basata sulla tolleranza, sulla cultura della pace e sull'inclusività. Questo è il punto focale del patrimonio connettivo, e il Sentiero della Pace (Walk of Peace) è uno dei migliori esempi di connettività, basato su un passato travagliato e conflittuale, ma proiettato verso un presente e un futuro connettivi.
Kamil Ruszała (Jagiellonian University): I siti della Prima Guerra Mondiale sul Fronte Orientale ci ricordano quanto profondamente la guerra abbia plasmato le comunità locali e intere regioni. Attraverso GOV4PeaCE, traduciamo queste esperienze in strumenti educativi che promuovono empatia, resilienza e riflessione critica. Per le giovani generazioni, imparare a conoscere un passato bellico condiviso e multiculturale aiuta a superare gli stereotipi nazionali e a comprendere quanto fossero strettamente interconnesse le società europee. Monumenti e cimiteri diventano messaggi di pace e responsabilità umanitaria: insegnano la cura per i defunti, rivelando al contempo l'assurdità della guerra di fronte a centinaia di migliaia di tombe sparse. Il patrimonio serve quindi non a glorificare il conflitto, ma a comprenderne le conseguenze e a utilizzare tale conoscenza per costruire solidarietà e un futuro più pacifico.
Prospettive dei Partner e Eredità del Progetto
Dopo aver stabilito una rete e maturato esperienza nella cooperazione transnazionale nel campo del Patrimonio della Prima Guerra Mondiale, il progetto GOV4PeaCE ha esteso le sue reti, creato nuovi strumenti e modelli per la collaborazione transfrontaliera. Guardando al futuro, i suoi partner riflettono su quanto è stato raggiunto e su ciò che verrà. Dalla prospettiva della vostra istituzione, quali sono stati i risultati più importanti del progetto finora? Come immaginate la continuazione della cooperazione dopo la conclusione del progetto GOV4PeaCE?
Maša Klavora (Walk of Peace Foundation): I risultati più importanti finora includono la creazione di solide reti di cooperazione transfrontaliera: tra Polonia e Slovacchia – e persino Ucraina – tra Ungheria, Romania e Serbia, e tra Slovenia e Italia (attraverso quattro regioni, non solo Friuli Venezia Giulia e alcune aree del Veneto). Anche il Belgio è coinvolto in tutte le attività. Questo ha permesso lo scambio di pratiche e conoscenze e la preparazione di nuovi progetti congiunti. Abbiamo inoltre svolto un vasto lavoro di ricerca: abbiamo identificato circa 400 siti del patrimonio della Prima Guerra Mondiale in tutti i Paesi partecipanti e li abbiamo presentati sulla piattaforma del Sentiero della Pace. In aggiunta, stiamo conducendo numerose attività di capitalizzazione e sinergia con altri progetti Interreg e iniziative correlate. Stiamo sviluppando un modello di governance e uno strumento online che i partner potranno utilizzare nei loro processi di sviluppo del patrimonio anche dopo la conclusione del progetto. Guardando al futuro, speriamo che nell'autunno 2026, alla conclusione del progetto, tutti i partner intenzionati a proseguire questo lavoro firmino un accordo sostenuto da un piano d'azione e una piattaforma transnazionali, garantendo così la cooperazione a lungo termine. Il Sentiero della Pace e i suoi progetti finanziati dall'UE sono stati anche presentati nell'ottobre 2025 alla Settimana Europea delle Regioni e delle Città a Bruxelles come esempio di buona pratica. Naturalmente, sarà necessario ulteriore lavoro concreto nell'ambito di futuri progetti transfrontalieri Interreg o di altri schemi di finanziamento – proprio come abbiamo fatto negli ultimi 15 anni con Soča Regional Development Agency, PromoTurismo FVG, GECT GO, municipalità, ZRC SAZU e altri partner nei programmi Interreg Italia–Slovenia, e più recentemente all'interno del quadro della Capitale Europea della Cultura Nova Gorica–Gorizia 2025. A livello molto personale, ciò che conta di più per me è la sensazione che le persone che lavorano su GOV4PeaCE e su altri progetti del Sentiero della Pace non siano solo colleghi ma anche amici: persone che rimangono in contatto a lungo dopo la fine dei progetti e che sono veramente dedicate a questo argomento.
Francesco Frizzera (MITAG): Dal punto di vista dei partner di GOV4PeaCE, i risultati più significativi raggiunti finora sono fondamentalmente relazionali e cognitivi. Il progetto ha stabilito con successo nuove e robuste partnership transnazionali e ha promosso una cruciale consapevolezza dell'esperienza condivisa oltre i confini istituzionali. Il processo di mappatura collaborativa ha rivelato impressionanti simmetrie e analogie: nonostante i diversi contesti nazionali, i modelli, le procedure e le sfide relative alla gestione e allo sviluppo di questo patrimonio comune sono straordinariamente simili. Questa consapevolezza è la chiave dell'eredità del progetto. Utilizzando strumenti e piattaforme comuni, tutti i partner sono implicitamente costretti a considerare le azioni e i piani di sviluppo dei loro omologhi, garantendo una sinergia a lungo termine. Guardando al futuro, la continuazione della cooperazione sarà guidata da queste comprensioni condivise. I piani futuri includono la promozione di progetti di ricerca comuni che vadano oltre il settore accademico e l'espansione della rete di percorsi del patrimonio (come il Sentiero della Pace) come strumento promozionale condiviso. Questa integrazione consapevole della collaborazione nel futuro pensiero strategico assicura che i modelli innovativi di gestione e di istruzione sviluppati durante GOV4PeaCE si evolvano in una missione condivisa, garantendo il futuro di questo patrimonio europeo ben oltre la conclusione ufficiale del progetto.
Il Futuro dei Percorsi del Patrimonio Europeo
Una delle ambizioni a lungo termine di GOV4PeaCE è, infatti, espandere la rete di sentieri del patrimonio europeo e connettere nuove regioni, creando una vera e propria mappa continentale della memoria. Come vedete il futuro sviluppo dei percorsi del patrimonio europeo? Quali passi sono necessari per integrare nuove regioni, come il Fronte Orientale, nella più ampia rete del Sentiero della Pace (Walk of Peace)? Che ruolo giocano le municipalità transfrontaliere e le reti locali nel mantenere e promuovere i percorsi tematici della Prima Guerra Mondiale, e come possono contribuire a rafforzare i legami tra patrimonio, turismo e istruzione?
Petra Svoljšak (ZRC SAZU): L'obiettivo principale di tutti i progetti legati al Sentiero della Pace (Walk of Peace) è la creazione di una rete di diversi percorsi della memoria basati sul patrimonio della Prima Guerra Mondiale, che colleghi gli ex fronti Orientale, Occidentale, Sud-occidentale e Sud-orientale, formando così le basi per un Itinerario Culturale Europeo. Gli Itinerari Culturali Europei sono un'iniziativa dal basso (bottom-up) che necessita del forte sostegno delle comunità locali e delle municipalità, ma anche di diversi programmi turistici ed educativi. Richiederebbe un consiglio di gestione transnazionale efficace e un solido comitato scientifico in grado di espandere l'idea e i valori del Sentiero della Pace in tutto il continente. Uno degli obiettivi è anche trovare partner validi nell'Europa Sud-orientale che detengono un patrimonio enorme e significativo della Prima Guerra Mondiale, che in passato ha rappresentato un pilastro costituente della memoria nazionale e che rappresenterebbe un valore aggiunto alla rete esistente del Sentiero della Pace. Ciò potrebbe anche contribuire ai processi di allargamento dell'UE. Un'altra ambizione della rete esistente è l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, ma questa decisione necessita del supporto degli Stati e di una forte azione diplomatica. La Slovenia sta certamente mirando a questo obiettivo; la parte slovena del patrimonio dell'ex fronte dell'Isonzo è già inclusa nella Lista Tentativa UNESCO (2016). L'obiettivo o ambizione finale sarebbe espandere l'iscrizione a quanti più siti della memoria e del patrimonio della Prima Guerra Mondiale possibile, idealmente riuniti in un'unica e unita iscrizione, in grado di trasmettere il messaggio di pace e tolleranza.
Il Ruolo dei Musei
Poiché il Sentiero Europeo della Pace e gli altri percorsi del patrimonio connettono paesaggi storici oltre i confini, i musei svolgono un ruolo altrettanto vitale come centri (hub) di queste memorie disperse. Essi non solo curano mostre, ma collegano anche siti locali, comunità e narrazioni transnazionali. In che modo istituzioni come l'InFlandersFields Museum, il Museo Storico Italiano della Guerra e il progettato Museo del Fronte Orientale a Gorlice riflettono questo ruolo ampliato – legando prospettive nazionali e transnazionali e trasformando lo spazio museale in una rete viva di patrimonio oltre le sue mura?
Francesco Frizzera (MITAG): Il museo è il fulcro regionale o nazionale per lo sviluppo del patrimonio e l'indispensabile mediatore culturale all'interno della rete di memorie disperse. Istituzioni come l'In Flanders Fields Museum (Ypres) o il Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto) hanno ampliato i loro ruoli ben oltre la curatela di mostre. Essi fungono da elemento centrale che connette la triade essenziale del patrimonio: Oggetti/testimonianze materiali; Siti significativi/paesaggi trincerati; Persone/protagonisti/cimiteri. Il museo, sia come hub fisico che come istituzione, connette e media questi luoghi, storie e manufatti sia all'interno delle sue mura sia attraverso concetti di museo all'aperto (open-air museum). Esso funge da potente perno di una rete regionale, offrendo servizi cruciali – ricerca, istruzione e interpretazione – agli attori locali più piccoli, i quali sono vitali per la conservazione in loco. Con la sua forza comunicativa, si collega a livello nazionale e stabilisce relazioni internazionali con altre istituzioni regionali paritetiche. Fondamentalmente, il museo è il punto di articolazione per i percorsi del patrimonio e i sentieri escursionistici, fornendo il necessario contesto accademico e i servizi culturali quando è richiesta la mediazione. Senza questa istituzione centrale, lo sviluppo di un sistema coerente di valorizzazione territoriale e la fornitura di servizi essenziali di ricerca e educativi sono gravemente ostacolati.
Stephen Lodewyck (In Flanders Fields Museum): L'In Flanders Fields Museum raccoglie, ricerca e presenta la storia e il patrimonio della Prima Guerra Mondiale in Belgio. Il museo non si limita a raccontare la storia storico-militare, ma evidenzia l'impatto totale della guerra sulle persone e sul loro ambiente. Il museo dà voce alle molteplici prospettive e opinioni sul tema della guerra e della commemorazione da allora in poi, facilitando la discussione, per quanto controversa possa essere. Il museo e centro di ricerca incoraggia persone e comunità in tutto il mondo a condividere le loro storie e il loro patrimonio legati alla Prima Guerra Mondiale in Belgio. Laddove possibile e appropriato, questa collezione condivisa di storie e patrimonio viene nuovamente proposta ai visitatori del museo, preservando e rafforzando così lo spazio museale come una rete viva di patrimonio. L'In Flanders Fields Museum conferisce significato al patrimonio bellico in tutte le sue forme, sia all'interno che all'esterno delle sue mura. Il museo, ospitato nella Halle aux Draps (Halle dei Tessuti) di Ypres, un lieu de mémoire nella regione dell'ex linea del fronte, presta grande attenzione al paesaggio contemporaneo come uno degli ultimi testimoni tangibili della storia della guerra. Vari tour, percorsi e applicazioni che esplorano l'ex paesaggio di guerra partono dal museo e collegano diversi siti della Prima Guerra Mondiale – sia reperti bellici che luoghi della memoria – in modo pedagogicamente responsabile, conferendo significato al paesaggio per i residenti e i visitatori di oggi. Connettendo attivamente paesaggi, luoghi e persone in tutta la regione e oltre, il patrimonio diventa rilevante per il mondo di oggi e di domani.
Kamil Ruszała (Jagiellonian University): Seguendo le buone pratiche sviluppate dai musei della Prima Guerra Mondiale in Belgio e in Italia, e creando reti con altre istituzioni in tutta Europa, il progettato Museo del Fronte Orientale a Gorlice tratta la cooperazione transnazionale come un principio strutturale piuttosto che come un'aggiunta. Il museo mira a diventare un centro (hub) per il patrimonio disperso nel paesaggio, integrando siti locali, fonti archivistiche e ricerca internazionale in una narrazione europea più ampia che superi l'eroismo nazionale. Istituzioni come l'IFFM (In Flanders Fields Museum) e il MITAG (Museo Storico Italiano della Guerra) offrono modelli stimolanti su come i musei possano agire come centri di memoria distribuita, collegando paesaggi storici, strumenti digitali e comunità locali. La nostra ambizione in Polonia è costruire una piattaforma che segua queste idee. In questo senso, i musei diventano ponti: essi traducono la complessità delle esperienze belliche in conoscenza accessibile, promuovendo al contempo il dialogo transfrontaliero e partnership a lungo termine.
Comunità Locali e Partecipazione Pubblica
La conservazione del patrimonio non è solo un compito istituzionale, ma anche uno sforzo comunitario. Come possono essere coinvolte le comunità locali nella protezione e promozione del patrimonio della Prima Guerra Mondiale? In che modo la loro partecipazione contribuisce a costruire una cultura della memoria sostenibile?
Maša Klavora (Walk of Peace Foundation): Il primo passo essenziale è sensibilizzare sull'importanza del patrimonio della Prima Guerra Mondiale e sulle opportunità che esso offre alle comunità locali. Per questo motivo, i residenti locali dovrebbero essere coinvolti nei processi di protezione e promozione fin dall'inizio: solo un approccio partecipativo può condurre a una cultura della memoria e a pratiche commemorative di successo e sostenibili. Qualsiasi modello imposto, dall'alto verso il basso (top-down), creerebbe un ambiente negativo e ostacolerebbe lo sviluppo di programmi di turismo culturale o educativi basati sul patrimonio, lasciandoli come mere idee sulla carta.
Stephen Lodewyck (In Flanders Fields Museum): L'In Flanders Fields Museum connette la raccolta di patrimonio, la conoscenza e la ricerca sulla storia della Prima Guerra Mondiale con i residenti, i visitatori e le comunità di oggi. Un programma culturale diversificato e ampie attività educative, mirate a un vasto spettro di gruppi scolastici – dalle comunità (del patrimonio) locali ai visitatori (scolastici) (inter)nazionali – mirano a connettere diverse comunità. Il museo intrattiene un rapporto continuo e profondo con gli Amici dell'In Flanders Fields Museum (Friends of the In Flanders Fields Museum), che ne sostengono la missione e supportano il funzionamento del museo e del centro di ricerca. Inoltre, gli Amici contribuiscono al programma museale attraverso le loro attività. Organizzano eventi commemorativi, passeggiate, escursioni e viaggi in patria e all'estero. Il loro viaggio nel passato della Prima Guerra Mondiale segue le tracce dell'umanità in tempo di guerra e, lungo il percorso, ricercano i meccanismi della guerra e della pace, per mostrare il significato di questo passato per il mondo di oggi. Gli Amici agiscono come "il primo pubblico" dei programmi e delle mostre del museo.
Questo scambio rende chiaro un punto: quando la storia condivisa diventa responsabilità condivisa, l'eredità della Prima Guerra Mondiale acquisisce un nuovo significato per l'Europa di oggi. Grazie per questo forum.
Klavdija Figelj, Responsabile delle Relazioni con i Media della Capitale Europea della Cultura 2025 Nova Gorica - Gorizia, giornalista.
Foto: Tanja Gorjan
Lead Partner
Posoški razvojni center
Partner del progetto
Ustanova Fundacija Pot miru v Posočju
ZRC SAZU Zgodovinski Inštitut Milka Kosa
PromoTurismoFVG
Vegal
Italian War History Museum Rovereto
Gorlice City
Association of the Carpathian Euroregion
Administration of the Poloniny National Park
Self-Goverment of Town of Mórahalom
In Flanders Fields Museum
Maggiori informazioni sul progetto: Building on past heritage for future development - Interreg Central Europe